L’immortale eco della Scrittura
Intervista a Jacopo Lavezzoli
a cura di Luca Carbonara
In principio erat verbum , dal Vangelo di Giovanni, e la parola era con Dio, a indicare la genesi e, insieme, la corrispondenza, la totale adesione della stessa parola con Dio, con il principio di tutto: che cos’è per te la parola e dove nasce?
Iniziando dalla visione mistica, che lei mi suggerisce citando il vangelo, posso dirle che la parola è stata investita di potere magico molto prima della nascita del cristianesimo: nelle culture più antiche, come quella egizia e mesopotamica, la parola non era solo un mezzo di comunicazione, ma uno strumento capace di influenzare il mondo. Gli Egizi credevano che la “heka”, ovvero la magia, fosse attivata proprio dalle parole. Nei rituali, le formule pronunciate con precisione potevano chiamare gli dei, proteggere l’anima nel viaggio verso l’aldilà, o persino manipolare il destino. Lo stesso accadeva tra i Sumeri e gli Accadi, dove gli incantesimi orali servivano a invocare le divinità o scacciare gli spiriti maligni. Anche in India, nella civiltà vedica, i mantra erano visti come potenti strumenti capaci di plasmare la realtà: il suono delle parole aveva il potere di mantenere l’equilibrio del cosmo.
Ma la parola non ha bisogno di poteri magici per assumere un ruolo fondamentale nella storia umana; da un punto di vista antropologico, essa è stata il fondamento stesso dell’evoluzione sociale. Senza la parola non avremmo potuto tramandare conoscenze, raccontare storie, creare legami tra individui. L’antropologo Claude Lévi-Strauss sosteneva che i miti e le leggende non erano semplici racconti, ma sistemi di pensiero che riflettevano la struttura sociale di una comunità.
E, da scrittore, non posso non parlare della parola dal punto di vista dello storytelling: Will Storr, nel libro: La scienza dello storytelling, insegna il valore antropologico del raccontarsi storie. Sono migliaia di anni che gli umani si tramandano informazioni attraverso narrazioni avvincenti, e questo processo è diventato parte di noi, del nostro modo di pensare e conoscere. I lettori di oggi sono figli di una tradizione antichissima e rispondono alle sollecitazioni emotive secondo aspettative e criteri ben precisi. Alimentare la curiosità, innescare l’empatia, coinvolgere la memoria… sono tutti meccanismi che fanno parte di un sistema definibile e studiabile che si chiama, appunto, storytelling.
Mentre preparavo l’esame di psicologia generale, avevo letto qualcosa di molto interessante riguardo alla relazione che intercorre tra la vastità del vocabolario conosciuto da un individuo e il suo livello intellettivo. Confesso che per risponderle ho dovuto riprendere in mano qualche vecchio libro. È stato Lev Vygotsky a sostenere che il linguaggio non è solo uno strumento per comunicare, ma un mezzo per pensare. Più parole conosciamo, più siamo capaci di articolare pensieri complessi e risolvere problemi. Anche in alcuni test del QI è presente una valutazione delle capacità linguistiche e del vocabolario.
Anche se, forse, la sorprenderà sapere che la più importante lezione sul valore delle parole non l’ho appresa durante gli studi di psicologia, ma nel periodo in cui preparavo gli esami di giurisprudenza: ricordo che nel corso dell’esame di diritto costituzionale, al primo anno, un me molto più giovane e ignorante ha risposto che: “il decreto legge viene messo sulla gazzetta ufficiale e diventa legge solo dopo 60 giorni.” L’assistente mi rispose un secco “no.” Io pensai di aver sbagliato la tempistica. “Forse erano 80 giorni?”. Ancora lo stesso “no”. Dopo avermi lasciato arrovellare per qualche minuto, l’assistente mi bocciò dicendomi che i decreti legge non vengono messi sulla gazzetta ufficiale, ma pubblicati. Non la presi bene, all’epoca, pensai che il senso avesse più importanza della forma, ma in seguito imparai che l’uno perde valore senza l’altra. Scegliere la giusta parola può valere un esame all’università e molto di più.
Infine, non posso non menzionare Stephen King, che, nel celebre libro On Writing: A Memoir of the Craft, alla domanda: “Come scrivi un libro?”, ha risposto: “One word at a time”, ovvero “Una parola alla volta”. Questa affermazione racchiude una verità essenziale: ogni parola è un tassello di un’opera più grande. Scrivere è una costruzione paziente, e ogni parola, scelta con cura, contribuisce a creare una storia solida e coerente. La parola, che nei millenni ha avuto il potere di influenzare la magia e la società, rimane oggi il cuore pulsante della narrazione.
Che cosa significa per te scrivere? C’è in esso una tensione etica? I tuoi studi, di giurisprudenza prima e di psicologia clinica poi, come hanno influenzato la tua scrittura in termini di stile, visione e ispirazione? E in termini di scandaglio psicologico dei personaggi?
Per me scrivere è molte cose: un atto catartico intimo e personale; un canale che mi permette di convertire i pensieri più grezzi ed emotivi in concetti più raffinati e razionali; è comunicazione nella sua accezione più nobile, ovvero Arte, che si tratti di un quadro, una scultura, una sinfonia o un libro, ogni forma d’arte permette all’autore di trasmettere il suo mondo interiore al pubblico, comunicando ciò che prova, ciò che è. L’etica e la scrittura hanno sicuramente dei punti di contatto, ma bisogna stare attenti a non sfociare nella didattica, per poi franare nel proselitismo. Un buon libro sa affrontare temi etici senza schierarsi: gridare al mondo le proprie opinioni attraverso le parole di un personaggio è meschino, e giustamente allontana i lettori. Nell’Antico Mortale ho mostrato alcuni conflitti essenziali: tradizione contro innovazione, giusta guida contro libero arbitrio, coerenza verso i propri obbiettivi contro capacità di adattamento… Attraverso le azioni dei personaggi ho mostrato dove possono condurre certe scelte, ma spero di aver lasciato abbastanza spazio per le riflessioni dei lettori.
Già nella risposta alla prima domanda ho accennato ai miei studi, posso aggiungere che la laurea in legge mi ha permesso di comprendere alcuni aspetti interessanti relativi alla gestione del potere, alla costruzione della società, al modo in cui le persone si accordano per raggiungere i propri fini e come questo abbia sempre un prezzo. La società stessa ha un prezzo molto salato: il bene della collettività supera l’interesse del singolo, l’istinto naturale viene addomesticato e piegato a norme e costumi, i bisogni primari vengono veicolati e strumentalizzati al fine di creare un sistema relativamente prevedibile e gestibile attraverso leggi e regolamenti. Ognuno di noi paga un caro prezzo di libertà per ottenere sicurezza e stabilità.
Mi sono laureato in legge senza sapere cosa ne avrei ricavato, ma quando ho deciso di tornare all’università per conseguire la seconda laurea in psicologia, l’ho fatto per passione. Comprendere perché le persone fanno ciò che fanno è sempre stato il mio desiderio primario. Ovviamente non ho trovato una risposta assoluta, ma, tra gli studi e le esperienze di vita, ho sviluppato una buona competenza nel costruire modelli mentali che, per rispondere alla sua ultima domanda, sono essenziali per sviluppare personaggi coerenti e profondi.
Pensi a una persona che le è cara e che conosce da molto tempo, potrebbe essere sua moglie, il suo migliore amico, sua madre… immagini di avere una conversazione con questa persona. Sono certo che riuscirà a prevedere ogni sua risposta, magari vedrà anche come si muove, gesticola e si aggira per la stanza.
Io potrei vivere per anni isolato dal mondo – in certi periodi della mia vita l’ho fatto davvero – perché nella mia mente converso continuamente con un’infinità di persone. Alcuni miei amici si risentono perché non mi faccio sentire per mesi, ma io parlo con loro continuamente.
Negli anni, ho sperimentato quanto le mie conversazioni simulate fossero logiche e veritiere, ho predetto il comportamento di diverse persone a distanza di mesi o anni, ricevendo poi conferma dei miei pronostici.
Studiare psicologia mi ha certamente aiutato a sviluppare questa capacità, ma sono così tante le esperienze e le nozioni che hanno contribuito a formare la persona che sono oggi, che non saprei proprio come riassumerle tutte in questa intervista.
Che cosa significa per te vedere e qual è il tuo rapporto con la realtà, come ti sentiresti di definirla e che cosa è per te reale? C’è una componente magica in essa e qual è la chiave per coglierla?
Da un punto di vista neurologico, vedere, sentire, toccare… sono tutti stimoli raccolti dai nostri recettori che vengono poi convertiti in impulsi bioelettrici che viaggiano attraverso il sistema nervoso per arrivare al cervello. E una volta arrivati, che succede? Credo sia quello il punto e il luogo in cui la sua domanda trova la lacuna della scienza in cui dare spazio alla magia.
Senza allontanarci troppo da ciò che è dimostrabile e verificabile, fermiamoci un istante a riflettere sul fatto che il mondo che vediamo è solo una ricostruzione parziale e artificiale. Esistono molti più colori di quanti ne colga l’occhio umano, esistono spettri luminosi che non possiamo percepire, ognuno di noi ha un punto cieco nel capo visivo che viene riempito da un’ipotesi plausibile del nostro cervello. E stiamo parlando soltanto della vista. Tutti i nostri sensi sono estremamente limitati e imprecisi, anche la memoria è molto meno affidabile di quanto si pensi. Quindi, il mondo che crediamo di vedere è quello che realmente ci circonda? Sì e no. Sono un uomo pragmatico e preferisco una buona risposta euristica a una credenza fideistica.
Ognuno di noi sa che potrebbe morire il giorno seguente, investito da un’auto o colpito da un asteroide, perché no? Ma scegliamo ugualmente di scrivere la lista della spesa, di compilare l’agenda, di cominciare la dieta, di accettare l’invito a cena di uno spasimante… perché? Perché l’alternativa sarebbe l’immobilismo. Se ci fidassimo solo di ciò che è certo al 100% non potremmo fidarci di nulla e periremmo di stenti in una morsa di terrore. Più o meno consciamente, approssimiamo le stime, e ciò che è molto probabile diventa certo, ciò che è successo negli ultimi vent’anni accadrà anche domani. Il sole sorgerà ancora, il rosso sarà sempre rosso e io domani non verrò colpito da un asteroide.
Quindi, che si tratti della trama di un libro o della vita quotidiana, la definizione di “reale” è il frutto di una scelta, non di un fatto.
Come nasce in te la predilezione per il genere fantasy, deriva forse da un’irrisolta conflittualità con la stessa realtà che ti circonda, o piuttosto dal desiderio di reinventarla, di sublimarla? Quanta verità e/o lungimiranza nell’immaginazione?
Devo premettere che, per ragioni di marketing, l’etichetta del genere letterario di un libro va scelta per individuare il target di riferimento; la mia trilogia è classificata come “thriller”, ma immagino che lei si stia riferendo al “fantasy” secondo la sua accezione letterale, ovvero di fantasia, intesa in contrapposizione a tutto ciò che è reale. In tal senso, anche horror e fantascienza possono essere considerati “fantasy”.
Detto ciò, io sono un estremista: non racconterei mai una storia “reale”, proprio come non amo leggerle. Potrei dire che la realtà non si batte; quando voglio una storia vera apro la finestra, ascolto la gente al bar, telefono a un amico, faccio un viaggio, ascolto i miei pazienti… siamo letteralmente immersi nella realtà, c’è davvero bisogno di raccontarsela anche nei libri? Non confondiamo reale con realistico, mi raccomando! Anche la più assurda storia di fantasia è bella solo se mantiene vivo il “patto di sospensione dell’incredulità”, e questo significa che a partire dall’introduzione dogmatica: gli alieni esistono, possiamo viaggiare nel tempo, abbiamo clonato i dinosauri… tutto ciò che seguirà dovrà essere logico e razionale. Il principio di causa/effetto deve essere sempre rispettato!
Io ritengo che un libro, o un film, siano finestre che qualcuno apre su mondi alternativi che altrimenti non potremmo vedere. Un dono meraviglioso! Inestimabile. Per questo motivo, scrivo storie di fantasia con solide basi scientifiche, faccio ricerche storiche, mi documento e spendo nottate a prendere appunti e sviluppare ipotesi. Per donare ai lettori uno scorcio su qualcosa che non possono trovare da nessun’altra parte. Un’esperienza unica e autentica che la vita reale non può offrire.
Quanta verità c’è nell’immaginazione? Se scegliamo di crederci per tutta la durata della lettura, c’è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E quando chiudiamo il libro, le emozioni che rimangono sono autentiche.
Tu sei autore di un’opera davvero ponderosa, la trilogia La Genia d’Oro suddivisa nei tre volumi Il Diario Segreto di Edgar Stone, Cercando Amy e L’Antico Mortale, l’ultimo della serie appena edito che si differenzia e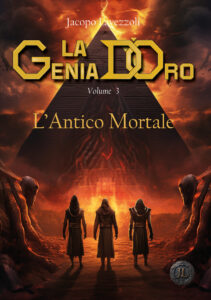 distingue per il diverso stile narrativo, che passa dalla forma diaristica al romanzo, e per il soggetto declinato in terza persona. Che cosa ha voluto dire per te in ultima analisi realizzare questa impresa letteraria che ha comportato una lunga ricerca storica, documentaristica e dialettica, un continuo confronto tra storia, anti storia, miti e leggende? Quali sono i limiti della ricerca storica? La si può disgiungere da una ricerca filosofica?
distingue per il diverso stile narrativo, che passa dalla forma diaristica al romanzo, e per il soggetto declinato in terza persona. Che cosa ha voluto dire per te in ultima analisi realizzare questa impresa letteraria che ha comportato una lunga ricerca storica, documentaristica e dialettica, un continuo confronto tra storia, anti storia, miti e leggende? Quali sono i limiti della ricerca storica? La si può disgiungere da una ricerca filosofica?
Il primo libro della trilogia nasce come un progetto molto più piccolo e privato: ispirandomi ai racconti di Lovecraft, in cui spesso il personaggio narrante racconta di aver trovato un diario, avevo deciso di scrivere a mano, ogni sera, calandomi nei panni di Edgar Stone, prendevo nota, disegnavo mappe, codici, appunti. Al termine del lavoro, invece di regalare il manoscritto a un amico, decisi che il risultato finale meritava la pubblicazione. Così l’ho trascritto al computer, cercando di salvare lo stile originale.
In seguito mi sono chiesto cosa ci fosse oltre i confini della Rocca, il laboratorio segreto in cui si svolge il primo libro, così ho deciso di allargare la scena scrivendo un secondo diario, in cui il nuovo narratore racconta il suo viaggio alla ricerca della fidanzata scomparsa, finendo nello stesso mistero che aveva risucchiato Edgar Stone. Il primo libro diventa parte integrante del secondo, inquanto viene ritrovato dal nuovo narratore. In un mix di azione anni 80’ e thriller scientifico in stile M. Crichton, il secondo romanzo si rivela essere una storia adrenalinica che alza il livello dei misteri. Dall’ambiente chiuso della Rocca, si passa alla Colombia, fino a scopre che il mondo intero è coinvolto, che le risposte sono sepolte nel passato e una grande guerra sta per sconvolgere il pianeta.
Il terzo libro ha richiesto molto più lavoro rispetto ai precedenti; attraverso il narratore onnisciente ho risposto a ogni quesito lasciato in sospeso, ho raccolto i semi pazientemente distribuiti nei primi libri. Si scopre la vera identità di personaggi quasi dimenticati, si svela la cospirazione che stava dietro agli esperimenti e i due veri contendenti scendono in campo per combattere la battaglia finale.
Non ho trovato particolari limiti nel corso della ricerca storica: al giorno d’oggi le informazioni sono facilmente reperibili, spesso possiamo trovare quello che stiamo cercando senza bisogno di sapere se esista veramente. Mi spiego meglio, ipotizziamo di voler dimostrare che il caffè è cancerogeno: basterà cercare su Google “il caffè è cancerogeno” e appariranno svariate informazioni. Volendo, potremmo alzare il livello del nostro lavoro cercando su Google Scolar, o altre piattaforme simili, per trovare ricerche e pubblicazioni scientifiche. Poi proviamo a cercare: “il caffè previene il cancro”, e troveremo altrettante informazioni.
La storia, le pubblicazioni scientifiche, le ricerche antropologiche, le religioni, i miti e le leggende, rappresentano un mare magnum di informazioni, in cui è possibile affermare tutto e il contrario di tutto, in perfetto stile sofistico. Per ricollegarmi alla sua domanda sulla filosofia, credo che, se oggi Socrate potesse tornare in vita, si divertirebbe moltissimo a navigare su Internet. Diventerebbe il peggiore dei Troll che infestano forum e social.
Qual è il tuo rapporto con il Tempo? È sempre sinonimo di evoluzione? Smetterà mai la guerra di essere lo strumento principe di risoluzione dei conflitti tra i popoli?
Domanda interessante. In effetti ho sempre avuto un rapporto difficile col tempo, con la sua ineluttabilità e con la mortalità. A 18 anni, all’esame di maturità, scrissi una tesina dal titolo: Il desiderio di immortalità, riportando esempi di come questo desiderio umano sia stato promotore di evoluzioni in campo artistico, filosofico, sociale e culturale. La paura della morte e il mistero che l’accompagna è alla base di ogni religione. L’essere umano è l’unico animale che vive con la consapevolezza che un giorno dovrà morire. È un peso titanico che trascina sul fondo del nostro inconscio una serie di timori e riflessioni che ci condizionano ogni giorno.
Il rapporto tra tempo ed evoluzione non descrive una curva ascendente: Ai tempi in cui l’antropologia era una materia da salotto, si era soliti suddividere le diverse popolazioni secondo una gerarchia evolutiva, convinti che le tappe fossero facilmente inseribili lungo una linea progressiva. Ma questa errata convinzione venne smentita dal lavoro di Franz Boas, che nel 1896 pubblicò il celebre saggio: The Limitations of the Comparative Method of Anthropology, dimostrando che le culture seguono percorsi distinti, influenzati da fattori storici e ambientali unici. Boas introdusse il concetto di “relativismo culturale”, sostenendo che le società umane non possono essere classificate su una scala evolutiva fissa e che la diversità culturale è una manifestazione naturale di condizioni diverse.
Nel corso delle ere si sono evolute e poi estinte un’infinità di specie e, di volta in volta, non si è verificato un processo di perfezionamento vero e proprio. L’evoluzione, che si parli di specie, cultura, arte, moda, o altro, non è mai definibile in termini assolutistici come un miglioramento o un peggioramento. Esso si forgia nel crogiolo del contesto – o ambiente, volendo mantenere una terminologia darwiniana – migliore è ciò che meglio si adatta al contesto, peggiore è ciò che soccombe. Ma il contesto muta in modo entropico, imprevedibile.
Quanto alla guerra e al suo perpetrarsi nel futuro della società umana, credo che sia molto difficile fare una previsione. Se intendiamo la guerra nella sua accezione di “conflitto”, essa esisterà finché ci sarà vita. Ogni organismo vivente è in conflitto con l’ambiente per mantenersi in equilibrio. In ogni istante, il nostro corpo combatte contro batteri, funghi, virus, replicazioni cellulari fallate che potrebbero sviluppare tumori, variazioni di pressione, temperatura… il conflitto è inevitabile.
Ma volendo considerare la guerra come estrema espressione “violenta” della società umana, la faccenda si fa molto più interessante. La violenza è la prima e l’ultima risorsa: la prima che sperimentiamo quando siamo bambini e reagiamo aggredendo ciò che non capiamo, ciò che ci disturba; l’ultima che rimane quando siamo messi spalle al muro e dobbiamo scegliere se combattere o morire. Con il progredire della società si è ampliato molto il segmento che sta tra questi due punti. Gli strumenti che ci permettono di risolvere i problemi senza ricorrere alla violenza sono sempre di più e l’educazione alla nonviolenza è sempre più incisiva. Questo fa ben sperare.
Ma rimane da considerare il fatto che la guerra sta trovando nuovi modi per esprimersi, in assenza di violenza. Basti pensare alle guerre economiche, batteriologiche, mediatiche… Forse smetteremo di vedere uomini che uccidono altri uomini sul campo di battaglia, ma il conflitto per il potere continuerà a mietere vittime in modo più subdolo e indiretto.
Finché comanderanno le persone che desiderano comandare, invece di quelle più adatte per il compito, ci sarà sempre guerra.
Quali sono i tuoi programmi e progetti futuri?
Ho di recente terminato la prima stesura del mio prossimo libro. Sono lieto di raccontarle brevemente qualcosa su “Le Catene dello Spazio” ambientato nel 2500 (il titolo è provvisorio). In questo romanzo di fantascienza si intrecciano tre trame principali:
Silas Ryu, il leader di un gruppo di ribelli marziani, progetta di colpire una delle società interplanetarie più potente e corrotta, per mostrare al popolo la verità che sta dietro alla colonizzazione di Marte. Inoltre, cerca di ottenere vendetta per ciò che gli è stato fatto: sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, gli sono stati somministrati psicofarmaci per disturbi che non aveva, causandogli danni permanenti, con conseguenti allucinazioni e paranoie.
Matilda Reed, la presidentessa della Matt-poli, sta per realizzare il suo sogno di potere: dopo anni di duro lavoro, legale e non, ha finalmente l’opportunità di impadronirsi di ciò che le occorre per diventare la persona più potente del sistema solare. Ma, senza la guida della madre, Matilda fatica a gestire l’enorme carico di stress e si imbatte in una serie di ostacoli imprevisti.
Su Edelgord, un pianeta alieno, vive una razza evoluta e senziente, con una società paradossale fondata sulla codipendenza. Gli edeli hanno quattro sessi: femmine, maschi bianchi, maschi rossi e neutri. La società è matriarcale e le famiglie hanno forma triangolare, inquanto per procreare è necessaria l’unione di una femmina, un bianco e un rosso.
I neutri sono rarissimi, ognuno possiede una particolare maestria innata che lo rende un genio innovatore. Xellar, un neutro con la maestria per la fisica e l’ingegneria aerospaziale, viene convocato per partecipare a un consiglio con il compito di salvare il pianeta da una glaciazione imminente. Edelgord è sull’orlo della catastrofe per aver sfruttato eccessivamente le energie rinnovabili, (luce solare, energia eolica, moto ondoso, geotermica…) innescando un progressivo abbassamento delle temperature, che ora ha raggiunto il punto di non ritorno.
Attraverso le avventure di questi tre personaggi, Le Catene dello Spazio mostra le criticità della società moderna, lo sviluppo ipotetico che rischiamo di dover affrontare e il grande inganno delle meccaniche economiche. Attraverso paradossi e metafore, vengono prese in considerazione le lacune della struttura sociale contemporanea e vengono proposti spunti di riflessione socio-filosofica che aprono la strada al miglioramento.




