La notte più buia. Cronache di una generazione.
Racconto di un’epifania
Intervista a Roberto Gramiccia
a cura di Luca Carbonara
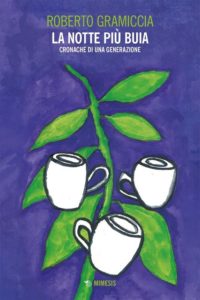
Scorrendo le pagine di La notte più buia. Cronache di una generazione (Mimesis), non si può non cogliere l’estrema duttilità, da un lato, dello spirito vitale e creativo dell’autore, dall’altro, del suo pensiero a dar vita a un multiforme ingegno e a una poliedrica forma mentis: da scrittore a medico a critico d’arte: chi è Roberto Gramiccia e come si amalgamano e dialogano tra loro grammatiche e declinazioni così diverse del pensiero?
Sicuramente una figura non in linea con i tempi. Tanto per capirsi: uno che pensa che per fare il medico bene non è sufficiente essere aggiornato ma devi essere colto, sensibile, devi saper comunicare, devi riconoscere i segni. Augusto Murri soleva ripetere che un vero medico non può non essere un filosofo. E ancora, Renato Caccioppoli, nelle sue lezioni universitarie, sosteneva, mutatis mutandis, che un grande matematico non può che essere un poeta. E Burri, come Cechov Céline Bulgakow Levi laureato in Medicina, è stato uno dei massimi artisti visivi del Novecento. Di questi eroi è fatto il mio Pantheon. Sono uno che pensa che la cultura e la scienza sono entità unitarie e indivisibili. Che le competenze e le specializzazioni servono, ma guai se si sostituiscono a una visione integrale della realtà. “Il vero è l’intero” diceva Hegel e l’aver disperso questo insegnamento ha prodotto guai insanabili nella cosiddetta post-modernità. È per questo che, considerando la medicina più un’arte che una scienza o una tecnica, mi sono senza imbarazzi occupato di arti visive, non potendomi, ovviamente, disinteressare delle vicende del mondo, dei destini degli ultimi e dei diseredati, dei fragili: di politica quindi, nella sua accezione più nobile di “etica della polis”.
I titoli delle sue opere, che coprono significativamente un ventennio, dalla vigilia dell’avvento del nuovo Millennio alla vigilia della “sua” Notte più buia, vale a dire dal 1999 al 2019, sembrano essere, forse non a caso, ognuno un fotogramma, la cristallizzazione di un momento preciso della storia, significative istantanee della condizione dell’uomo e l’impressione che se ne trae, leggendoli in successione, tra asserzioni (La medicina è malata, 1999), ossimori (La regola del disordine, 2004; Fragili eroi, 2009) e parafrasi (Vita di un matematico napoletano, 2015), è che sembrano essere prodromici di questa sua nuova opera. Qual è il filo conduttore, se c’è, che lega queste opere, c’è una vena di nichilismo che le attraversa o, al contrario, un’esaltazione della vita, della natura in grado, ribaltando Dostoevskij, di salvare la bellezza e in che termini la medicina è malata?
L’attuale medicina clinica è malata perché è ostaggio del mercato, vittima dell’iper-specialismo e utilizza la tecnologia come un fine e non come un mezzo. Mi lusinga che lei abbia colto un possibile filo conduttore che tiene uniti i numerosi libri che ho scritto in un ventennio. Forse ce n’è più di uno. Ma, volendo fare uno sforzo per individuare quello principale, penso che esso possa essere rintracciato nella valorizzazione del concetto di fragilità, intesa come condizione ontologicamente determinata, che non condanna necessariamente alla sofferenza e alla minorità ma, a determinate condizioni, rappresenta la precondizione del riscatto, del progresso, della stessa sopravvivenza della specie. In questo senso l’esatto opposto del nichilismo. In qualche modo una specie di religione laica che può assumere forme etiche, estetiche e di prassi trasformatrice e rivoluzionaria.
Facendo riferimento al suo saggio Arte e potere. Il mondo salverà la bellezza (2015) qual è oggi lo stato dell’arte e come si è evoluto il suo rapporto con il potere?
Si tratta di temi per me cruciali che ho affrontato nel libro da lei citato e in Se tutto è arte… (Mimesis). Quest’ultimo si occupa, in modo più discorsivo dell’altro, dello stato attuale dell’arte: una condizione di prevalente soggezione ad un sistema che riconosce nel business, piuttosto che nella qualità dell’arte, il suo interesse principale. Il tratto fondamentale dell’arte post-contemporanea si può ricondurre alla (triste) constatazione che al concetto di valore, mutevole nel tempo, si è sostituito quello di prezzo: l’opera più ricercata è oggi quella che costa di più, non quella che ha più qualità. In questo senso: “qualsiasi cosa può essere arte” a condizione che sia “artistizzata” (Perniola), cioè riconosciuta come tale da coloro che detengono il potere di certificarne l’esistenza (curatori, direttori di museo, case d’asta, grandi collezionisti ecc). Mentre in passato l’arte spuntava la sua autonomia in una negoziazione continua con il potere (politico, religioso, comunicativo). Oggi il potere, tendenzialmente, tiene l’arte a catena. Ne consegue, inevitabilmente, un suo progressivo deperimento.
Il sottotitolo della sua ultima opera edita da Mimesis, “cronache di una generazione”, traduce lo scopo del suo ultimo intento narrativo che, oltre che per i riferimenti di carattere più personale, si caratterizza per la sua vis ironica e divertente, ma qual è la generazione cui si riferisce e che ha inteso raccontare? Quanto accaduto dopo il 2019, quel momento di crisi individuale e collettivo causato dalla pandemia da Covid-19, con la paura e l’ansia da contagio, non ha corrisposto piuttosto a una crisi trans generazionale che tutti indistintamente ha coinvolto e in qualche modo stravolto?
La generazione di cui si narra la storia, attraverso una collezione di episodi tendenzialmente a spunto autobiografico, proposti in ordine non cronologico, è quella che va dalla metà degli anni Cinquanta sino ai giorni della terribile pandemia. Un lungo periodo che i miei più o meno coetanei ritroveranno nei loro ricordi e i più giovani conosceranno, attraverso una testimonianza diretta, forse per la prima volta. Sulla natura transgenerazionale della crisi prodotta dalla pandemia concordo, anche se è indubbio che a pagare il prezzo più alto sono state le fasce di età più avanzata.
In questo suo ultimo “saggio narrato” se da un lato c’è il racconto, con riferimenti autobiografici, fedeli o infedeli che siano, dai diversi e articolati toni anche ironici e divertenti, della paura e dell’ansia patite da un’intera popolazione presa alla sprovvista da un evento tanto imprevisto quanto drammatico e doloroso, dall’altro non c’è però il senso della resa, della sconfitta, ma piuttosto il desiderio di capire che cosa è realmente accaduto e che cosa siamo diventati. Ma non pensa, e in questo stanno le responsabilità della politica, che la pandemia sia stata come una sorta di enorme lente di ingrandimento che non ha fatto altro, in ultima analisi, che mettere nella più chiara evidenza i limiti e le disfunzioni di una società e di un modello in crisi irreversibili ormai da tempo? Una crisi quindi già in atto da tempo tanto materiale quanto morale?
Effettivamente lo stile narrativo che ho scelto è volutamente ironico e spesso divertito (spero divertente) perché uno dei rischi che mi è sembrato tassativo evitare è quello di un lacrimoso amarcord. Naturalmente non mancano fatti ed episodi tutt’altro che divertenti, essendo decisamente espressa, anche se in filigrana, la volontà di denunciare misfatti (la strategia della tensione ad esempio) e ingiustizie sociali che hanno infiltrato, come un tessuto canceroso, la nostra storia recente. Ma anche le vicende più drammatiche si mischiano con fatti e personaggi, notissimi e ignoti, che raccontano anche del grande vitalismo che permeò di sé soprattutto il trentennio glorioso che, dai Cinquanta, arriva sino alla fine degli anni Settanta. Un vitalismo che traspira dalle storie d’amore e di sesso rubato, da quelle di corna fatte e ricevute, da quelle di studio quasi “pazzo e disperatissimo”, dalla passione per l’arte, dalla ingenua convinzione di essere interni anzi artefici di un processo potenzialmente rivoluzionario, ma anche dalla tenerezza di storie familiari e di ricordi che parlano di una formazione fortunatamente maturata in un tempo in cui non esistevano solo idee deboli ma, viceversa, si intravedevano – a torto o a ragione – esaltanti orizzonti di gloria. Per capirsi: l’esatto contrario di quello che succede attualmente. Tempi di passioni tristi quelli di oggi, la cui pessima qualità è stata, per così dire, certificata dai milioni di morti prodotti da una pandemia che ha rivelato la caducità del sistema economico e sociale che informa di sé un Occidente capitalistico, oggi più che mai globalmente in crisi. Ma ancora una volta, persino la lettura che della pandemia si dà nel libro rappresenta un esempio vibrante di come, anche in un momento di fragilità e di paura estreme, si possano creare i presupposti di una matura rielaborazione della propria vita, finalizzata al tentativo di rifornire, fortificare e affinare una visione del mondo non rassegnata.
In ultima analisi, tornando al tema portante della sua opera La notte più buia, vale a dire il cruciale doppio interrogativo sul che cosa eravamo e che cosa siamo diventati, non crede che la risposta a questo interrogativo sia, e sia stata, si diventa ciò che si è? E, ancora, non pensa che il periodo più buio, quello della clausura individuale per tutti, avrebbe potuto corrispondere a un’occasione per ognuno per guardarsi dentro?
Nel mio caso è stato esattamente così: un’auto-analisi che ha preso la forma di un romanzo sui generis di quasi trecento pagine probabilmente, in assenza dell’isolamento coatto a cui la pandemia ci ha obbligato, non l’avrei mai portata a termine. Ho sperato e spero che questo viaggio retrospettivo non sia servito solo a me. Attraverso questa esperienza ulissica, infatti, è riemerso un mondo che rischia di cadere nell’oblio. Un mondo in gran parte figlio di un Secolo terribile e formidabile insieme: il Novecento. “Diventare ciò che si è” è una prospettiva che attiene, spinozianamente, ai limiti del nostro libero arbitrio. Nessuno, infatti, può prescindere dalla propria struttura genetica e dal vissuto ambientale che gli è dato di avere. La nostra libertà è sempre “quella che può essere”, quella che ci è concessa. La tensione che percorre il libro, la caffeina che si assapora, è quella che deriva dalla ricerca di un mondo che in vita una cosa almeno garantisca: la libertà dal bisogno materiale e spirituale. Una condizione sconosciuta ancora a miliardi di persone che abitano non soltanto i paesi sottosviluppati ma tutte le province di un mondo che non possiamo più tenerci così com’è.



